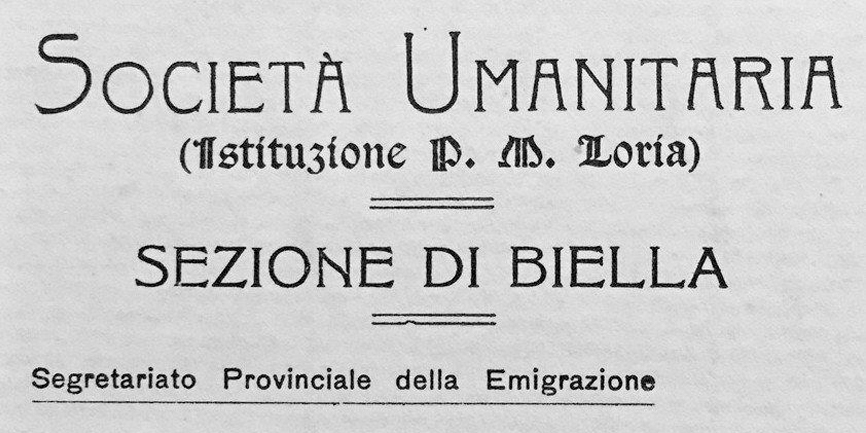A cura di Claudio A. Colombo
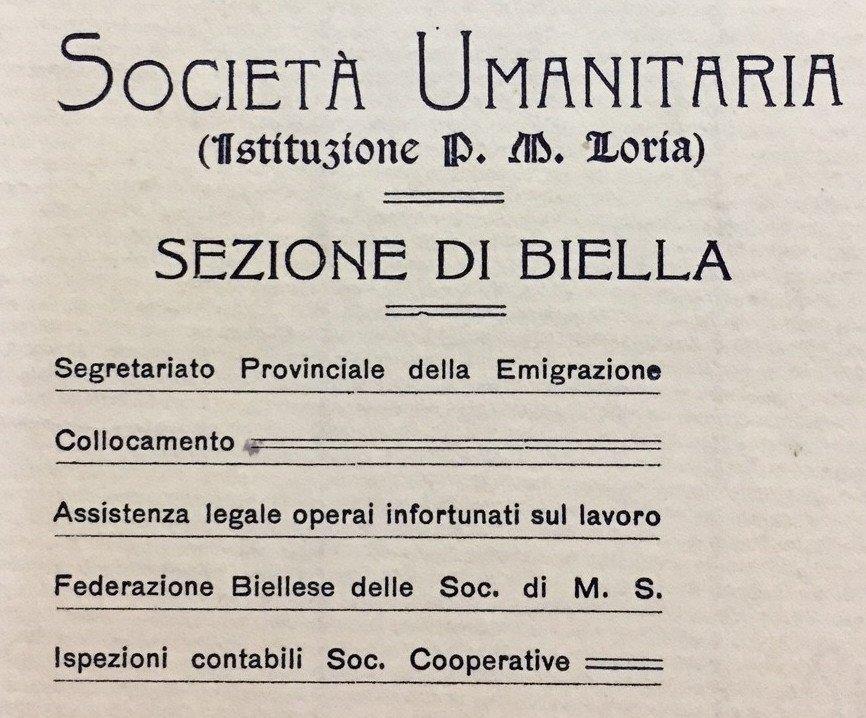
Nel febbraio 1923, a un anno di distanza dalla soppressione della sede, nel presentare la relazione morale del 1922, veniva sottolineato quanto la Sezione di Biella avesse svolto un’opera “intensa, multiforme, paziente e disinteressata, che ha soddisfatto una infinità di bisogni, lenito sofferenze, evitato soprusi e ingiustizie, consigliato ed assistito nelle più svariate contingenze le necessità della classe operaia di questa nostra industre regione”.
Erano passati quasi vent’anni da quando, nel 1904, per volontà della Federazione Nazionale Edile, della Camera del Lavoro e del Comune di Biella, il Consorzio dell’Emigrazione aveva fondato a Biella un suo Segretariato, funzionante a pieno regime fino al 1907 quando il Consorzio era stato sciolto. In realtà i primi contatti dell’Umanitaria con il territorio biellese risalivano al 1897, quando il Segretario dell’Ente, Osvaldo Gnocchi Viani, era stato interpellato dalla società cooperativa fra i cappellai del Biellese affinchè ne appoggiasse la costituzione e ne finanziasse il funzionamento (i moti milanesi del 1898 ed il commissariamento dell’istituzione milanese avevano frenato l’intesa).
Nel 1908 il Segretariato dell’Emigrazione veniva trasformato nella Sezione di Biella, direttamente dipendente dall’Umanitaria, i cui scopi venivano concordati con il preciso intendimento di ampliare gli orizzonti del lavoro da svolgersi in favore degli emigranti e delle classi operaie, espandendo ogni possibile intervento sociale: dalla consulenza medico-legale (nel 1918 l’ufficio fu riconosciuto dal Ministero per l’Industria Commercio e Lavoro) al collocamento, dall’istruzione popolare e professionale (con la diffusione del libro mediante l’Unione delle Biblioteche popolari e scolastiche) alle più idonee forme di mutualità e previdenza. Fu patrocinata l’assistenza agli operai infortunati sul lavoro e promosse sinergie con le organizzazioni operaie; fu dato impulso all’ufficio di collocamento e favorite le cooperative, curandone la regolarizzazione e l’iscrizione alla Cassa di Previdenza, insomma venne promossa ogni forma e servizio atto a migliorare intellettualmente ed economicamente il Quarto Stato.
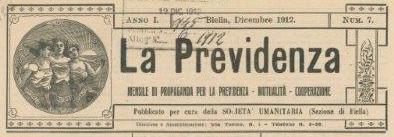
L’azione della Sezione fu quindi a 360 gradi e presto consolidò il suo operato nel campo dell’emigrazione (assistenza in patria e all’estero), della cooperazione (pubblicando persino una propria rivista “La Previdenza”), dell’istruzione popolare e professionale, estendendo il suo intervento anche a molti Comuni della Provincia: a Cossato, Croce Mosso, Coggiola,·Sagliano Micca, vennero istituiti insieme alla Camera del Lavoro sportelli periferici per il collocamento; a Zimone, Tavigliano, Intra, Pallanza gli ispettori della Sezione si attivavano per conoscere le condizioni degli emigranti e dare le necessarie disposizioni (nel 1914 vennero portate a termine 294 pratiche per ricupero salari dall’estero, restituendo oltre cinquantamila lire ai rimpatriati); a Mongrando, Ponderano, Cavaglià e Salussola vennero istituite scuole invernali professionali, diurne e serali.
Nel primo dopoguerra, con la ripresa dei flussi migratori di operai biellesi (nella quasi totalità dell’industria edile) venne creata la Sottosezione di Santhià, che istituì subito un Ufficio intermandamentale di collocamento, una Società mutua d’assicurazione per il bestiame, un Istituto medico-legale per gli infortuni sul lavoro.