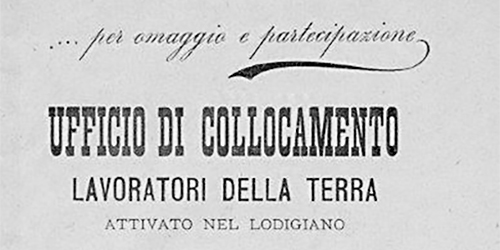A cura di Claudio A. Colombo
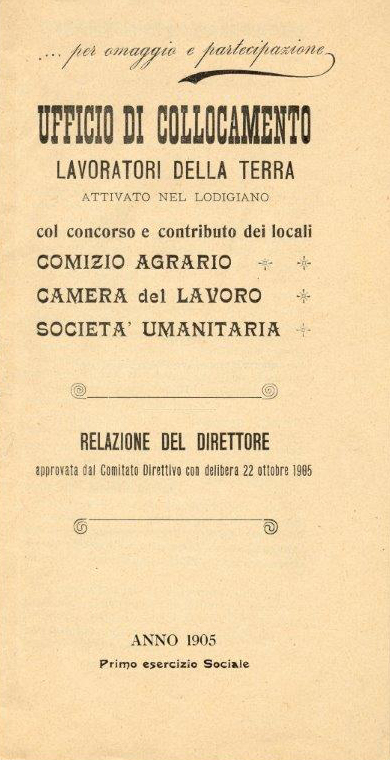
Nel 1905 l’Ufficio Agrario dell’Umanitaria fornì un contributo di rilievo alla nascita di una serie di uffici di collocamento per lavoratori dei campi a Lodi, Abbiategrasso, Codogno, Binasco, Melegnano, Melzo e persino a Milano. Insieme alle cooperative, gli uffici di collocamento nelle campagne dovevano svolgere un ruolo decisivo per l’elevazione delle plebi rurali. Gli uffici infatti non si limitarono a collocare la mano d’opera, contribuendo in tal modo a ridurre la disoccupazione, ma fecero anche un’opera “di tutela e di assistenza ai coloni collocati”, impegnandosi a fondo sia per risolvere le controversie tra datori di lavoro e lavoratori sia per far rispettare ai fittabili i patti colonici e per far pagare indennizzi agli inadempienti, cercando anche di migliorare gradualmente le condizioni delle abitazioni dei contadini, che non facevano certo invidia a quelle che si vedevano nelle più misere e nelle più arretrate regioni d’Italia.
L’esperimento degli uffici di collocamento nelle campagne (sussidiati fin dall’inizio dall’Umanitaria) si limitò inizialmente a Lodi e alla vicina Codogno, per poi estendersi a Melegnano, Abbiategrasso, Binasco, Melzo, in accordo con le organizzazioni operaie e sindacali dei rispettivi territori. Nel Lodigiano, almeno per i primi anni, tale supporto fu alquanto scarso, nonostante l’ufficio costituisse il primo anello di una lunga catena di riforme e di innovazioni che avrebbero dovuto essere attivate “a favore e incremento della locale agricoltura e nell’interesse reciproco dei rispettivi agricoltori e contadini”.
La scarsa collaborazione indusse l’Umanitaria a esercitare un più diretto controllo, facendo risiedere stabilmente presso l’Ufficio di collocamento un suo rappresentante, Luigi Minguzzi, che avrebbe avuto cura degli interessi e dell’assistenza ai lavoratori del Basso milanese. Fu così rimodulato il modus operandi, consistente nel procurare gratuitamente ai lavoratori il collocamento alle migliori condizioni possibili, nel vigilare affinché i contratti di lavoro fossero equamente e lealmente osservati, nel dare chiarimenti sulle eventuali controversie derivanti dal rispettivo contratto di lavoro. In tale ottica l’Ufficio si dedicò soprattutto a favorire l’incremento delle registrazioni dei contratti: se nel 1905 i contratti stipulati erano stati complessivamente 498, nel 1906 furono ben 783 e nel 1907 salirono a 988, grazie anche al battage esteso al territorio grazie alle succursali di S. Angelo Lodigiano e di Casalpusterlengo, che fecero acquisire una maggiore autorevolezza all’Ufficio di Lodi.
Riconosciuto per la sua condotta lineare, l’Ufficio potè prestò ampliare la sua azione anche al collocamento dei lavoratori dell’industria e personale di servizio, alla costituzione di Cooperative di lavoro e di associazioni di mestiere e all’attività di propaganda: 36 le conferenze tenute in molti Comuni del Lodigiano allo scopo di “persuadere i contadini a non affidarsi più all’opera dei mediatori ‑ vere sanguisughe – che nascondono e truffano le clausole migliori e più umane del nuovo patto colonico”.
Negli anni successivi, ci fu una contrazione dei contratti registrati e dei collocati: la crisi industriale provocò infatti l’aumento della disoccupazione e riversò nelle campagne manodopera disposta a lavorare per salari inferiori, cosa che causò uno sconvolgimento del mercato del lavoro. Ma l’Ufficio era ormai un’istituzione solida e consolidata, e così l’Umanitaria nel 1912 gli ridiede uno status autonomo e indipendente: il lavoro capillare aveva sviluppato una vera coscienza di classe tra i contadini, e la consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti per acquisirli.
Durante la guerra e nel dopoguerra l’Ufficio svolse un importante ruolo tecnico a supporto della Federterra, fino al suo scioglimento da parte del fascismo.