A cura di Claudio A. Colombo
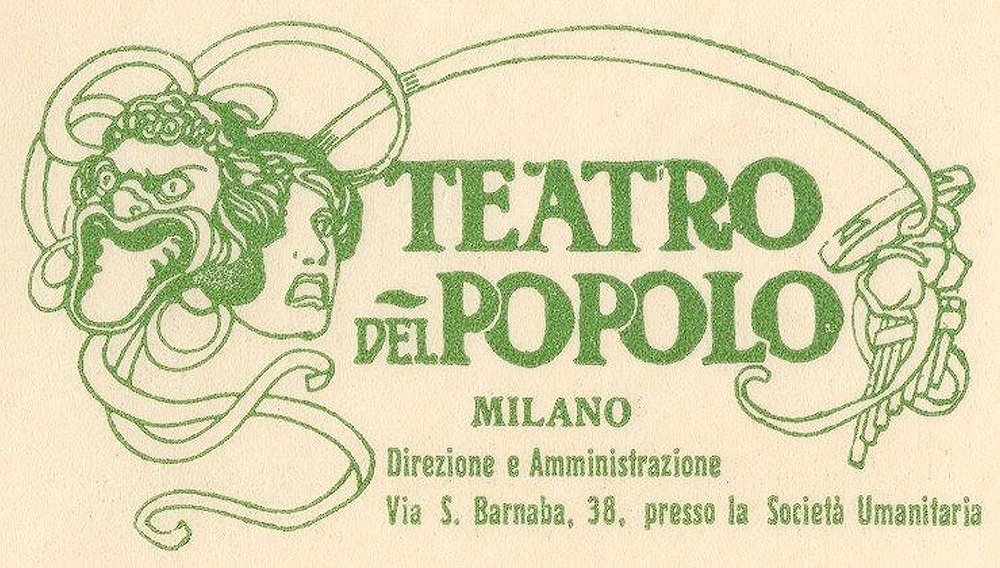
A pochi anni dall’inaugurazione del Teatro del Popolo (TdP), il Segretario Generale dell’Umanitaria, Augusto Osimo, pensava che tale strumento educativo non dovesse fermarsi solo al salone di via Fanti, ma divenire “ambulante per i diversi quartieri della città, nei quartieri veramente più popolari”. Poi, la Grande Guerra e l’impegno dell’Umanitaria su altri fronti. A partire dal 1920, la Commissione del TdP approvava il progetto dei teatri rionali: e anche se la spesa per “ammodernarli” fu molto pesante, si procedette a tambur battente, perché “bisogna andare al popolo, o meglio alla plebe per farla elevare a popolo”.
Sette i palcoscenici scelti, sulla scena la propria Compagnia Stabile (Sabatino Lopez, direttore artistico; Ettore Paladini, direttore di scena): Teatro Rionale di Porta Magenta, Teatro Rionale di Porta Garibaldi, Teatro Rionale “Arte Moderna”, Teatro Rionale “Figli del Lavoro”, Teatro Rionale Loreto, Teatro Rionale di Porta Genova, Teatro Rionale di Porta Vittoria.
Un progetto che ha rappresentato il primo esperimento di decentramento teatrale a Milano, di cui riportiamo alcune considerazioni tratte da un documento d’archivio del 1921.
“A sere alternate, nei più lontani rioni, il Teatro del Popolo reca un soffio d’arte. Emigra dalla sede centrale colla sua Compagnia al completo, s’installa sui palcoscenici e compie, con fervore, la sua squisita fatica. L’osservatore che frequenta queste sedi lontane rileva quanto pronta e viva sia l’anima della folla quando la sollecita uno spettacolo di serena gioia o di alta commozione.
Non è attenzione passiva ma comunione di pensiero, comprensione istintiva, gaudio inatteso. Ed un altro delicato legame scopre: quello fra popolo ed attori, destato da correnti immediate di simpatia, da godimento profondo, da torturante desiderio di capire come si gioisce e come si piange. Questo pubblico afferra tutto poiché è in lui la massima attenzione.
L’opera d’arte è così nelle condizioni ideali per essere accolta e compresa. È come un reciproco meraviglioso dono: l’attore reca la sua arte che tutto l’investe e travolge, lo spettatore la sua anima perché sia deliziata. E questa rispondenza il teatro rionale la raggiunge più perfettamente. Lo spettatore non è distolto dalla scena, la sua attenzione è centuplicata, la sua emotività è perfetta.
Sui palcoscenici rionali teatro di prosa, teatro di poesia, sono entrambi accolti, sentiti, gustati. La figura mordente e dolorante di Giannetta nella Cena delle Beffe, l’impotenza paterna a distogliere i figli in Come le foglie, l’angosciata Maternità, la violenza di Bufere, dell’Imboscata, della Nemica, la delicatezza della Maestrina, la forza dell’Onore e di Casa paterna, la vicenda umanissima del Romanzo di un giovine povero, tutto è compreso e sentito. E se, talvolta, il palcoscenico non permette vasto movimento, tuttavia il pubblico ne comprende le relative manchevolezze e le scusa poiché comprende che è nei voti del Teatro del Popolo creare altri più vasti ambienti, perché a tutta la folla che lavora giunga il conforto e la gioia dell’arte”.

