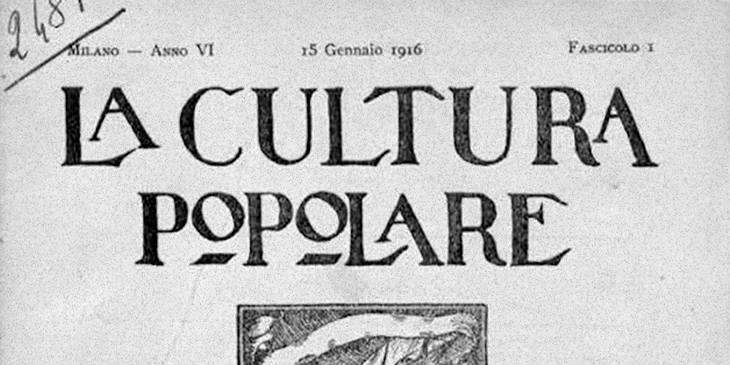A cura di Barbara Bracco
Nell’eterno dibattito sulla riforma della scuola italiana in ogni suo ordine e grado, può essere forse utile ricordare che l’Italia è stata – almeno nel secolo scorso – terreno fertile per dibattiti sulla pedagogia e sui problemi della scuola. A questa lunga tradizione scientifica italiana appartengono non solo le grandi riviste, ma anche quelle piccole testate che, pur essendo considerate tutt’oggi prive di qualche interesse storiografico, hanno comunque contribuito alla diffusione dei temi pedagogici ed alla creazione di un clima di intenso e profondo interesse per la scuola. Tra queste va sicuramente inclusa la “Coltura popolare”, uno dei periodici dell’età liberale più attenti ai temi della scolarizzazione in Italia.
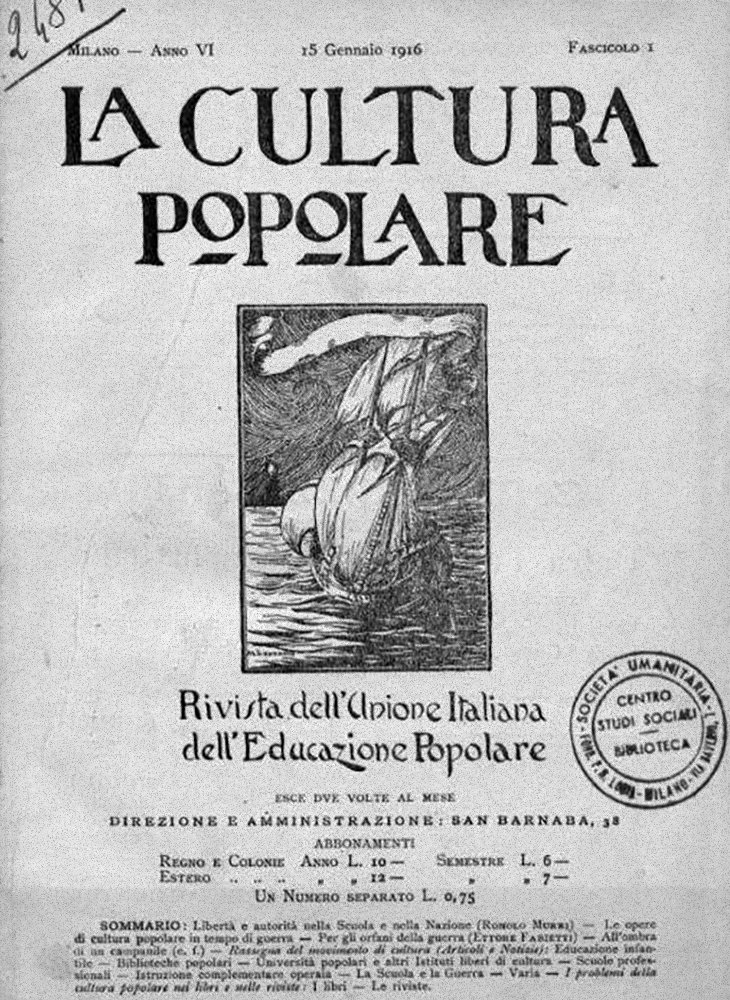

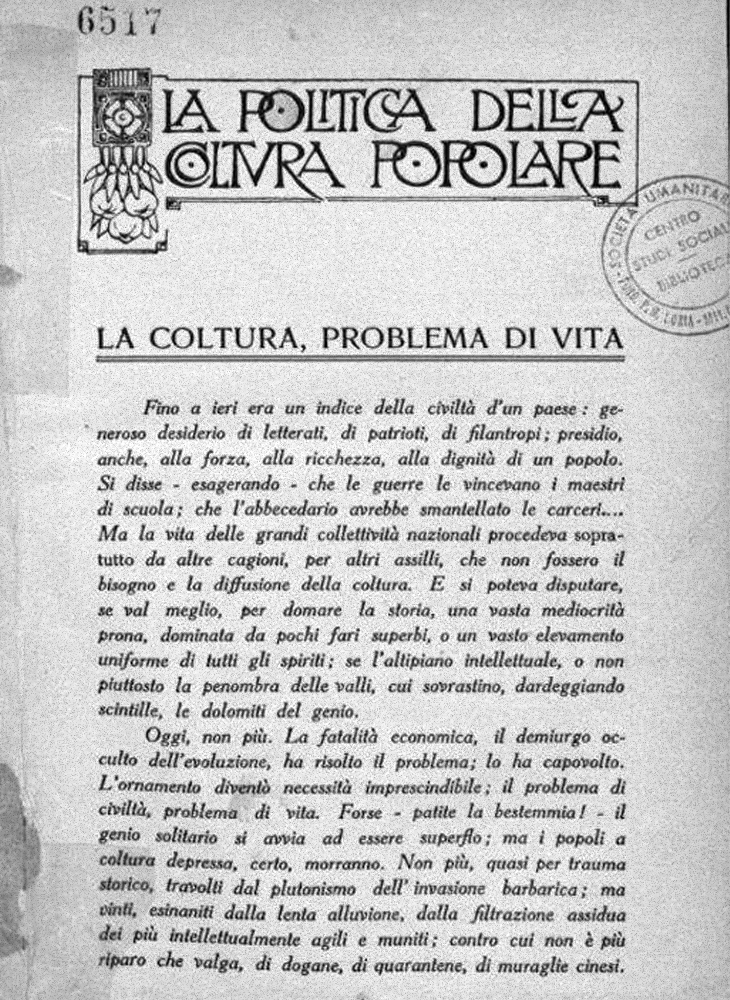
La rivista (che assunse poi il nome più moderno di “Cultura popolare”) trattò infatti tra il 1911 e il 1933, e poi ancora tra il 1950 e il 1977, i principali temi riguardanti la diffusione della scolarizzazione in Italia, i metodi più avanzati di insegnamento, l’istruzione degli adulti e degli emigranti, l’introduzione di nuove materie di insegnamento, l’istituzione di scuole professionali, insomma tutti quei temi che sono stati parte integrante del dibattito sulla cultura popolare, sviluppatosi in Italia nel corso del ‘900.
Organo della Unione Italiana dell’Educazione Popolare, il periodico milanese fu diretto nella fase iniziale da un comitato formato da Emidio Agostinoni, Ettore Fabietti, Silvio Varazzani e sotto la direzione di Augusto Osimo, Giuseppe Ricchieri, Eugenio Rignano, Rodolfo Rusca, Cesare Saldini, Filippo Turati. Esponenti del riformismo milanese già raccolti attorno alla Società Umanitaria, alle Università Popolari e alla Federazione delle biblioteche popolari, davano così vita ad un’iniziativa con un chiaro intento di pedagogia nazionale, non a caso assai elogiato da riviste come Critica Sociale e La Voce.
Malgrado l’evidente orientamento politico, si tendeva a prendere decisamente le distanze da ogni partito, vecchio o nuovo che fosse. “Nei partiti politici – si leggeva nel manifesto della rivista – noi scorgiamo oggi mai il bigio che invade. Nei vecchi partiti, che immiseriscono ogni giorno più nelle cabale sceme; nei nuovi, che han dato lo scossone alle genti assonate, e sembrano esausti, e van brancolando ancor essi. E l’egoismo li avviluppa, e lo sconforto li invade”.
In realtà, la rivista in più di una occasione assunse precise posizioni politiche. Lo fece certamente allo scoppio della Grande Guerra quando, a dispetto della neutralità dichiarata, il comitato direttivo si mise chiaramente in sintonia con l’interventismo democratico. Lo fece anche successivamente quando evidenziò il suo dissenso rispetto alla politica culturale del fascismo. Ciò non valse al periodico la sua salvezza. Nel 1933 il prefetto di Milano, considerando “pericolose” alcune osservazioni marginali del periodico, decise la chiusura della rivista, che solo dopo la seconda guerra mondiale sarebbe risorta con altri collaboratori e, naturalmente, altra impostazione.