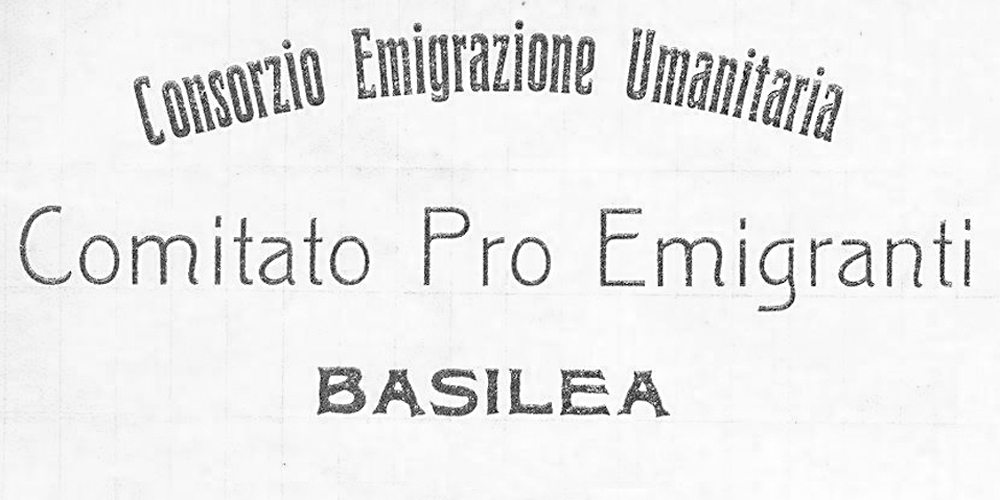A cura di Paola Signorino
Non appena decise di occuparsi d’emigrazione (1903), la Società Umanitaria si rese conto che per fornire un’assistenza accurata ai nostri connazionali bisognava mettere in piedi un gruppo di uffici nelle principali nazioni che erano le destinazioni degli emigranti. Nel giro di pochi anni, grazie alla collaborazione con i Segretariati laici di assistenza (istituiti fra il 1901 e il 1902), con le organizzazioni professionali sul territorio e con i sindacati di categoria, veniva perciò realizzata una vastissima rete di uffici decentrati uniformati ai principi della sede centrale milanese: tutti i centri erano in contatto tra loro e si trasmettevano – quasi in tempo reale – informazioni e statistiche utili al compito da svolgere.
Già nel 1909 veniva iniziato l’esperimento per un Ufficio di assistenza in Francia (prima a Marsiglia, poi a Modane nel 1912, e infine a Nancy nel 1918), mentre in Svizzera, Germania e Austria esistevano già undici centri sussidiati dall’Umanitaria a Lugano, Zurigo, San Gallo, Winterthur, Basilea, Strasburgo, Metz, Amburgo, Monaco di Baviera, Innsbruck e Villach.
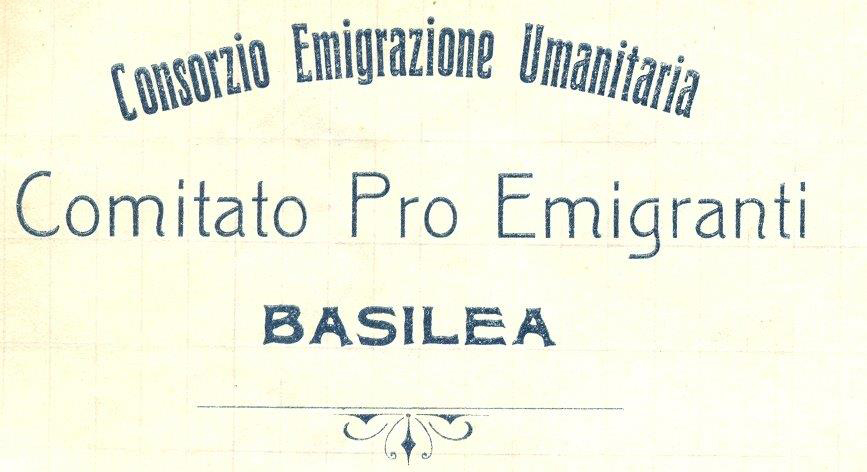
Grazie a esperti come Dino Rondani, Giovanni Walar, Nino Turati, l’opera degli uffici decentrati in Svizzera si estrinsecava in una moltitudine di attività, il cui punto di forza era la reperibilità di tutte le informazioni utili a scongiurare la pratica del krumiraggio, a tutelare i diritti degli emigranti (leggi e regolamenti), ad assicurare assistenza nei casi di infortunio sul lavoro all’estero e nei casi di invalidità.
I rapporti con le istituzioni locali erano assidui. A Lugano e Basilea, ad esempio, il sostegno dell’Umanitaria alla Camera e Segretariato del Lavoro del Canton Ticino e al Comitato Pro Emigranti Italiani era riconosciuto come un servizio nella sorveglianza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, spesso disattese dalle aziende locali. A Berna erano cicliche le visite effettuate dal dirigente dell’ufficio d’assistenza agli emigranti alle colonie italiane in Svizzera. Molto utile era anche il sodalizio con i giornali in lingua italiana delle organizzazioni sindacali straniere coinvolte – ad esempio l’organo dell’Unione Svizzera delle Federazioni Sindacati, “L’operaio”, stampato a Berna, oppure “L’Avvenire del lavoratore”, monitore del Partito Socialista Italiano in Isvizzera e dei Sindacati Italiani Federati al Gewerkschatbund di Lugano –, attraverso i quali si potevano lanciare appelli e dare informazioni certe sulle località dove si cercava manodopera.
Ma l’Umanitaria non pensava solo alle condizioni del lavoro e all’assistenza materiale (come per il progetto di un ricovero per emigranti di passaggio d’intesa con la Compagnia ferroviaria Berna – Loetschberg). Vi erano forme di intervento riguardanti gli aspetti dell’educazione degli emigranti (con larga attenzione verso gli aspetti dell’igiene e della pulizia), da portare avanti attraverso l’organizzazione di conferenze, la propaganda dei principi della previdenza (di concerto con il Comitato federale della Federazione delle cooperative italiane a Winterthur o con il Segretariato italiano della Svizzera orientale a San Gallo), l’elevazione culturale degli emigranti, come la Scuola di cultura popolare di Basilea o favorendo le attività dell’Università Popolare Italiana a Zurigo. Perché, come sosteneva con forza il deputato socialista Angiolo Cabrini, a capo dell’Ufficio emigrazione, “occorre illuminare, pulire, abituare a riflettere – non solo ad urlare e bestemmiare”.
Da segnalare, nel secondo dopoguerra, le numerose inchieste del “Bollettino quindicinale dell’emigrazione” sulle condizioni degli emigranti in Svizzera, ed il corso per animatori e dirigenti delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (Meina, 16-22 luglio 1972).