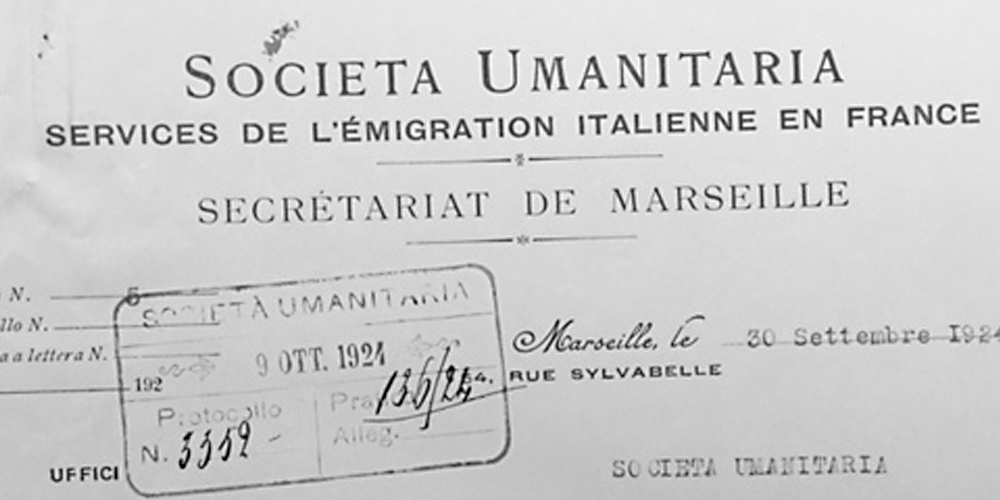A cura di Claudio A. Colombo
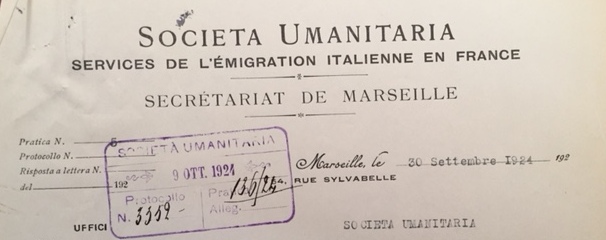
Nel 1923, a dodici anni dalla sua costituzione, la sede più longeva dell’Umanitaria in terra francese, quella di Marsiglia, era stata messa in condizione di estendere la sua opera a tutto il suo importante dipartimento: il sud della Francia. Istituita nel 1911 come Segretariato dell’emigrazione autonomo (nell’estate del 1914, in soli quindici giorni dovette assistere oltre 11.000 rimpatriati), nel 1921 la sede venne riorganizzata e trasformata in una Sezione direttamente dipendente dall’ufficio centrale di Milano: la situazione economica seguita al primo conflitto bellico imponeva un nuovo impegno sul fronte dell’emigrazione e del lavoro e gli sforzi vennero specialmente concentrati in Francia, divenuta la principale destinazione dei nostri emigranti, almeno prima della contrazione del mercato seguita alla crisi mondiale e ai successivi provvedimenti limitanti i passaggi alle frontiere.
Accanto a Marsiglia, l’opera di assistenza venne allargata grazie a due nuove sedi: la riapertura dell’ufficio di Modane, sede già esistente ma chiusa durante la guerra, il più importante snodo di confine della frontiera italo-francese, in Alta Savoia (90.000 gli emigranti transitati e assistiti nel 1923), e la nascita della sede di Nancy (confinante con l’Alsazia-Lorena), aperta alla fine del 1918, presto divenuta indispensabile centro di assistenza e tutela per circa 50.000 connazionali in una regione che richiedeva manodopera specializzata nel settore metallurgico. Tutte e tre le sedi avevano perciò anche il difficile ruolo di organi locali di reclutamento di manodopera.
Dirette da personaggi qualificati e riconosciuti, Domenico Salsa (Nancy), membro del Comitato di arbitrato per il trattato di lavoro italo-francese, Domenico Zavattaro (Marsiglia), corrispondente ufficiale del Commissariato Generale dell’Emigrazione, e Carlo Biorci (Modane), nativo del luogo e in perfetta sinergia con le istituzioni governative (come l’Office Departemental de Placement della Savoia e il Syndicat des Patrons), l’azione delle tre sedi dell’Umanitaria raggiunse presto anche i Dipartimenti vicini, dove si crearono 11 Sotto-Uffici a Aix, Arles, Cassis, Fos, Gardanne, La Ciotat, Marignane, Martigres, Salon nelle Bocche del Radano; a La Grand Gombe nel Gard; a Cannes-la-Bocca nelle Alpi Marittime. A questi Sottouffici si garantiva una presenza a cadenza fissa per poter espletare ispezioni e sopralluoghi anche in località limitrofe, come Trots, Fuveau e Cadolive. L’azione di assistenza veniva ulteriormente rafforzata attraverso i numerosi corrispondenti attivi in tutta la Francia: da Tolone a S. Raphael, da Fréjus a Brigloles, da Dramont a Nimes, da Avignon a Montauban.
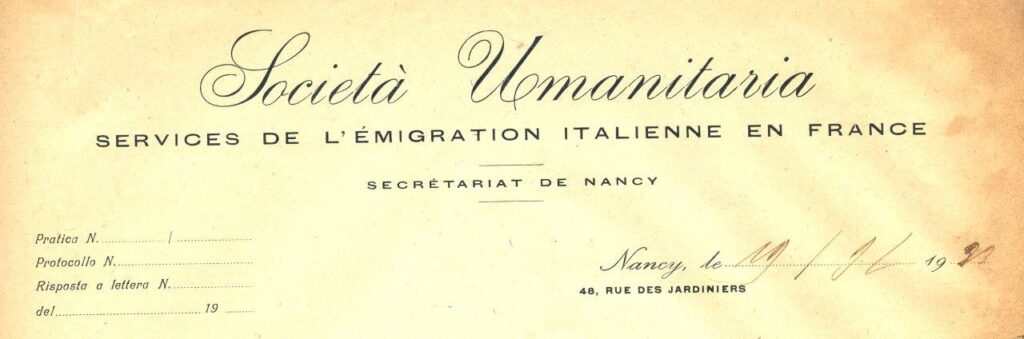
Diversificato e multiforme l’impegno delle tre sedi, in continuo contatto con l’ufficio centrale di Milano e con le più vicine sedi italiane dell’Umanitaria (in primis, Ventimiglia e Biella). La loro assistenza si presentava sotto svariate forme ed il lavoro si svolgeva e si rinnovava sempre, in base alle contingenze del periodo (migliaia le pratiche espletate ogni anno): collocamenti, richieste documenti, ricerche bagagli, sopralluoghi, infortuni, informazioni sui mercati di lavoro, partecipazione a commissioni arbitrali per assistenza legale sui contratti di lavoro, regolarizzazione di clandestini, e lotta agli sfruttatori, facendo spesso arrestare i pisteur che, col miraggio di un lavoro, truffavano i nostri emigranti. Così un resoconto del 1923: “è un vero piacere e una consolazione leggere negli occhi degli emigranti la loro contentezza ed udire dalle loro labbra parlanti i mille dialetti d’Italia le parole di ringraziamento. Per fortuna che esistono i nostri Uffici”.