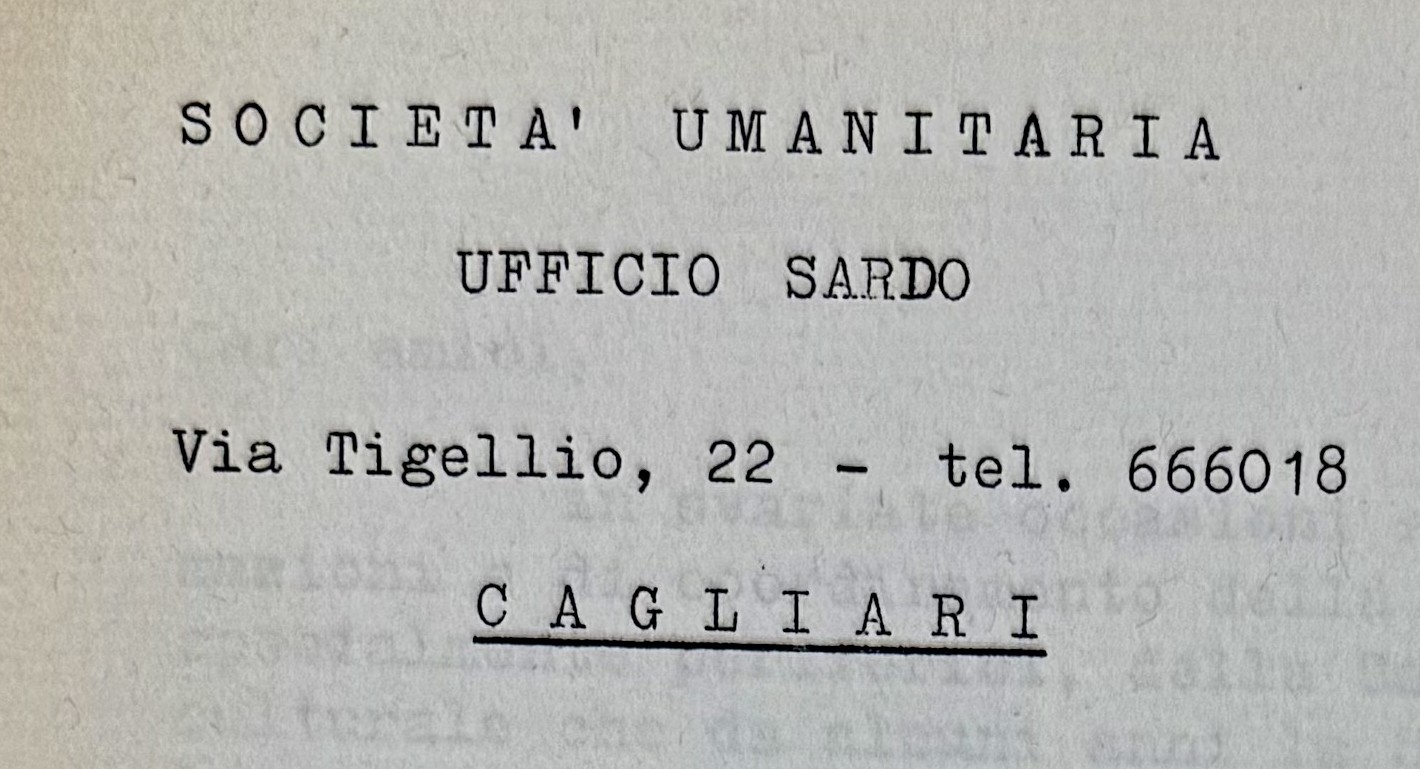A cura di Salvatore Figus
La sfida dei Centri Servizi Culturali in Sardegna
Sono trascorsi ormai cinquant’anni da quando i destini dell’allora giovane animatore culturale Fabio Masala, convinto cultore delle tematiche dell’educazione degli adulti, si incrociano con la vocazione della Società Umanitaria. Nel 1963 nasce il primo ufficio dell’Umanitaria e Fabio Masala ne diventerà il coordinatore, dando vita ad un’intensa attività di animazione culturale sul territorio regionale accompagnata a ricerche sulle condizioni socio-economiche dell’isola, che sfoceranno nel Progetto Sardegna e porranno le condizioni per la nascita della Cineteca Sarda.
Di seguito a quegli anni pionieristici, in cui si formerà una scuola di operatori culturali sardi, interverrà la nascita dei Centri di Servizi Culturali (CSC) che sono istituiti dalla Cassa del Mezzogiorno (CASMEZ) in tutte le Regioni del sud e nelle isole in base alla Legge 26 giugno 1965, n. 717. Nel 1967 verrà avviata l’attività dei CSC che per scelta governativa vengono affidati in gestione ad Enti di comprovata esperienza nel settore della formazione permanente. Si volevano sperimentare modelli di gestione snella ed efficiente in regime privatistico, ma con forte caratura di servizio pubblico.





I CSC, quali luoghi di animazione territoriale e fattori di crescita del fattore umano, vengono diffusi in tutto il territorio meridionale e alla Società Umanitaria ne viene affidata la gestione di cinque in Puglia (Bari, Foggia, Manfredonia, Altamura, Massafra) e tre in Sardegna (Cagliari, Iglesias, Alghero). Ai Centri vengono quindi attribuite competenze generali per quanto riguarda la promozione alla pubblica lettura, la collaborazione con gli enti locali nell’attività di programmazione culturale nell’ambito territoriale di ciascun Centro, l’incentivazione ed il sostegno dell’associazionismo, la sinergia con la scuola per lo svolgimento di attività culturali, facilitando l’attività didattica degli insegnanti, la promozione di corsi di aggiornamento per animatori ed operatori culturali, potenziando i servizi sociali, alla promozione professionale e alla mobilità territoriale.
Forse oggi è difficile cogliere la portata del carattere fortemente innovativo dell’intervento, ma si pensi solo al valore che ebbe l’apertura di una biblioteca e di un servizio di pubblica lettura in realtà che, quando andava bene, avevano qualche biblioteca di conservazione, dove le “bibliotecarie” rifiutavano assolutamente il prestito. La biblioteca viene fatta vivere come un centro di animazione culturale ed intorno ad essa vengono promosse attività culturali di vario tipo come cinema, teatro, presentazione di libri ed attività contro l’analfabetismo e la dispersione scolastica con il sostegno all’associazionismo culturale.
L’originaria formula gestionale sopravvive fino al 1972, quando si stabilisce che i CSC devono transitare alle Regioni. I CSC pugliesi verranno trasferiti alla Regione Puglia. I Centri sardi hanno continuato ad operare, in accordo con la Regione Sardegna, perché mai è venuto meno l’interesse dell’Umanitaria che ancora oggi ha in essere un piano di sviluppo della sua presenza nell’isola con l’ulteriore crescita della Cineteca Sarda e una stabilizzazione e riqualificazione del ruolo dei CSC sul territorio regionale.